Il quarantesimo anniversario dell’assassinio di Guido Rossa, ucciso dalle Brigate Rosse il 24 gennaio 1979, è stato accompagnato da un profluvio di retorica che, anche non volendo, annulla il significato della storia. Come se una morte infame fosse il suo unico merito. Bisogna allora ricordare l’esempio che Guido Rossa ha dato da vivo.
La sua vicenda viene così tramandata: operaio e delegato Fiom-Cgil all’Italsider di Genova, il 24 ottobre 1978 denuncia il compagno di lavoro Francesco Berardi per aver diffuso in fabbrica volantini delle Brigate Rosse. Esattamente tre mesi dopo, un commando della colonna genovese delle Br lo aspetta sotto casa e gli fa pagare la “delazione”.
Manca un dettaglio. Non è Rossa ma il Consiglio di fabbrica a voler denunciare Berardi. Vanno tutti insieme dai Carabinieri e alla battitura del verbale assiste “un numeroso gruppetto di operai e delegati”, come ricostruisce Giancarlo Feliziani in Colpirne uno educarne cento, primo e migliore libro su Rossa. Quando il comandante spiega che una denuncia penale non si può firmare “Il Consiglio di fabbrica” ma servono nomi e cognomi, “partono i primi ripensamenti. La stazione dei Carabinieri, come per incanto, a poco a poco si svuota”.
Rossa resta solo e da solo firma la denuncia. I brigatisti sanno subito chi è “l’infame”, aiutati anche dai giornali che allegramente stampano il suo nome. La sua sorte è segnata. Alla moglie che gli chiede perché l’ha fatto risponde: “Ognuno deve assumersi le sue responsabilità. Quando le cose si devono fare, si fanno”.
Sei mesi dopo, il 12 luglio 1979, viene ucciso a Milano Giorgio Ambrosoli, liquidatore della Banca Privata di Michele Sindona, mandante dell’esecuzione. Lascia alla moglie una lettera scritta quando capisce che finirà male: “Pagherò a molto caro prezzo l’incarico: lo sapevo prima di accettarlo e quindi non mi lamento affatto”.
Umberto Ambrosoli, che nel ‘79 aveva sette anni, dedica al padre parole che valgono anche per Rossa: “Sarebbero stati sufficienti anche solo silenzi, qualche piccola omissione, il non prendere posizione; avrebbe avuto salva la vita e con altissima probabilità sarebbe iniziata una brillante carriera nel mondo bancario”. Invece gli tocca solo il titolo di “eroe borghese” conferito dall’indimenticabile biografia di Corrado Stajano.
Guido Rossa, operaio comunista di 44 anni, lasciato solo dal governo Andreotti, ucciso dentro la sua Fiat 850 perché, quando le cose si devono fare, si fanno. Giorgio Ambrosoli, avvocato monarchico di 45 anni, lasciato solo dal governo Andreotti, ucciso dentro la sua Alfetta perché “lo sapevo e non mi lamento”. Sono la stessa cosa, due eroi borghesi.
Diverse classe sociale e idee politiche, li unisce un identico imperativo etico. Giulio Andreotti disse luciferino che “Ambrosoli se l’andava cercando”, e avrebbe potuto dire la stessa cosa di Rossa. Una confessione: per lui fare il proprio dovere e andarsela a cercare erano la stessa cosa, e con questa ripugnante equivalenza ha corrotto la classe dirigente italiana.
Il principio etico di Rossa e Ambrosoli è stato sradicato dalla mafia, dalle Brigate Rosse e dall’andreottismo. Colpendone due ne hanno educati centomila, e i più giovani non lo sanno, cresciuti dall’esempio di padri attenti solo a non cercarsela. Ad anteporre al proprio dovere l’obbedienza al potente. A non svolgere mai l’incarico ottenuto perché si occupano solo di non perderlo e soprattutto di usarlo come trampolino per nuove ambizioni.
Una classe dirigente fiera di insegnare ai giovani che chi parla di etica è un invasato. O, come dissero di Rossa le Br, facendo propria la truce cultura di Andreotti, “un mentecatto”.
Giorgio Meletti Il Fatto 27 gennaio 2019
Vedi: Un avvocato e la forza del dovere: GIORGIO AMBROSOLI
Rivalutare Andreotti è un insulto a chi lo Stato lo ha rispettato davvero
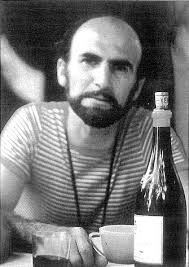
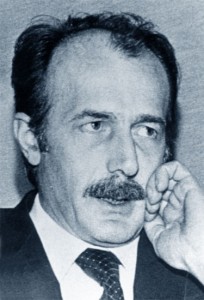


 In carica...
In carica...