Rivoglio la mia Milano. Senza cinema, teatri, musei e scuole l’esistenza si riduce al sostentamento del corpo. Anche l’incontrarsi viene depauperato: mica si può solo mangiare, acquistare o parlare di cibo
Alle 19,40 di domenica l’Esselunga di Porta Garibaldi a Milano sembrava la stazione Centrale in un’ora di punta. Le 30 casse aperte facevano fatica a smaltire le file dei carrelli stracolmi. Vuoti erano gli scaffali di carne, pasta, farina, uova, verdura, surgelati, per non parlare dei disinfettanti e dell’Amuchina. Piangente era anche il settore carta igienica, significativo emblema delle priorità degli acquisti.
 Sull’onda della paura di un coronavirus che in pochi giorni ha portato l’Italia al terzo posto fra le nazioni con più contagiati, i milanesi si sono affollati a comprare il comprabile, neanche fosse stata annunciata una guerra o una carestia. Come se fossero sotto assedio si sono comportati il giorno dopo, quando hanno lasciato deserte stazioni ferroviarie e mezzi pubblici.
Sull’onda della paura di un coronavirus che in pochi giorni ha portato l’Italia al terzo posto fra le nazioni con più contagiati, i milanesi si sono affollati a comprare il comprabile, neanche fosse stata annunciata una guerra o una carestia. Come se fossero sotto assedio si sono comportati il giorno dopo, quando hanno lasciato deserte stazioni ferroviarie e mezzi pubblici.
La metropoli emblema dell’efficientismo italiano si è così scoperta fragile e vulnerabile, soprattutto ben disposta ad autorecludersi tant’è che in questi giorni Milano non sembra più Milano, ma una città chiusa in casa e disertata, non spettrale ma scansata. Cinema chiusi (- 44% di incassi in una settimana), così come teatri, sale da concerto, musei, chiese, palestre, stadi, biblioteche, scuole, università, asili. Chiusi molti uffici.
Terminata in tono minore la settimana della moda che ha visto Giorgio Armani e Laura Biagiotti fare le sfilate senza pubblico. Chiusi i bar e i locali di ritrovo dalle 18 in poi, come se il rischio di contagio sia più pericoloso nell’ora dell’aperitivo piuttosto che durante cappuccino e brioche che, comunque, i milanesi hanno evitato in massa. I ristoranti invece possono tenere aperto perché, dicono, la distanza fra i tavoli darebbe una maggiore protezione, ma molti si stanno attrezzando per ridurre al minimo la vita di relazione.
C’è qualcosa di surreale in questa semi quarantena da zona gialla, dove si può uscire ma non vedere un film o una mostra, dove è ritenuto più rischioso andare a una conferenza che in un supermercato affollato, dove le scuole sono chiuse ma i negozi no, quasi che il diritto all’acquisto sia il limite da non valicare per non demoralizzare l’economia fino in fondo, dare una parvenza di normalità e mantenere i servizi essenziali. Vivere al minimo. In questo momento è necessario, ma svelante.
In nemmeno 24 ore è apparso evidente che è il cibo per la mente a fare di una metropoli un luogo attraente. Si possono tappezzare le vie di bar, ristoranti, negozi, ma se mancano i luoghi dove nutrire l’immaginario immediatamente manca il carburante della vita.
Senza cinema, teatri, musei e scuole l’esistenza si riduce a un sostentamento del corpo. A quel punto anche l’incontrarsi viene depauperato perché mica si può solo mangiare, acquistare o parlare di cibo. Si perde poi uno degli aspetti più affascinanti del vivere in città che è il poter decidere anche all’ultimo momento cosa fare, dove andare, che cosa vedere, chi incontrare, ovvero quel senso di possibilità infinite.
Si perdono occasioni. Lunedì sera al teatro alla Scala era previsto un attesissimo concerto di Maurizio Pollini, i biglietti esauriti da tempo. Cancellato, come ogni evento aperto al pubblico fino al primo Marzo. Certo, uno si può consolare ascoltando un disco a casa, ma sappiamo tutti che non è la stessa cosa perché è il rito dell’ascolto diretto a dare l’emozione primaria. Per contro, l’orchestra della Filarmonica lunedì pomeriggio si è spostata con un treno dell’alta velocità verso Roma, dove la sera ha tenuto un concerto, e per ora le prove d’orchestra non sono sospese, ma non è detto che possa accadere.
Si naviga a vista e alla giornata, si cambiano programmi, si spostano uscite, come quella del film di Giorgio Diritti su Ligabue «Volevo nascondermi» che, saltato il debutto a Milano e nel nord Italia, è stato spostato anche nel resto del Paese, come in un gioco del domino che mostra quanto siamo collegati, quanto siamo comunità e collettività, quanto abbiamo bisogno gli uni degli altri.
Non pochi sono gli effetti sull’economia, che poi significa volumi di affari per le aziende (la Borsa milanese ieri ha perso il 5,4%), ma anche compensi per i lavoratori che non sono tutti uguali, purtroppo. Prendendo un caffè in un bar ho sentito un cliente dire alla barista: «Ieri ero a un McDonald e hanno telefonato a tutti per dire di stare a casa oggi perché avrebbero chiuso». La barista: «Ma li pagano lo stesso?». Il cliente: «Mi sa di no perché sono a giornata». Lei: «Anche a noi converrebbe chiudere perché lavoriamo soprattutto con gli aperitivi, ma se dobbiamo tirare giù la saracinesca alle 18 andiamo in perdita».
Un’altra barista ha confessato che preferirebbe si chiudesse tutto «Perché – ha detto – che ne so io se un cliente è positivo o no? E se mi ammalo e infetto a mia volta qualcuno? Dicono che muoiono soprattutto i vecchi, ma io ai miei ci tengo anche se hanno la loro età».
La grande Milano sta facendo i conti con un nemico invisibile che ha mostrato come tutto è partito da un ospedale e che i più esposti sono medici e infermieri, la qual cosa dovrebbe far riflettere sui protocolli di protezione del personale.
L’emergenza passerà, prima o poi, ma intanto sarebbe bene far tesoro di quanto detto dal dottor Vittorio Agnoletto a Radio Popolare sulle ragioni di questo contagio così diffuso in Italia: «Da un lato non si è riusciti a individuare il “paziente zero” e quindi a intervenire sulla catena di trasmissione. L’altro aspetto è che la metà dei primi quindici casi coinvolgono pazienti ricoverati e personale medico delle strutture del Basso Lodigiano.
Il vulnus italiano non è tanto nell’organizzazione generale, bensì nelle indicazioni per gli operatori sanitari nei pronto soccorsi. La struttura sanitaria italiana è ridotta ai minimi termini per quanto riguarda gli interventi di primo livello: servizi territoriali e meccanismi di prevenzione soffrono di carenza di personale. La falla è individuabile lì». Adesso sappiamo quanto tutto ciò può costare.
Finito il pezzo scendo a prendermi un caffè. Accidenti, è tutto chiuso. Rivoglio la mia Milano.
Mariangela Mainiti Il Manifesto 24/2&/2020
Se la paura diventa malattia
La Logica di Port-Royal è un testo filosofico opera di due giansenisti francesi, Antoine Arnauld e Pierre Nicole, che lo pubblicarono, anonimo, nel 1662. In questo trattato i due autori si proponevano di studiare le regole della logica per giungere ad enunciare le regole del pensiero.
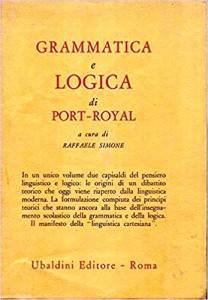 Perché ci interessa questo lavoro di due lontani (e sconosciuti, al di fuori della cerchia degli specialisti) filosofi francesi? Perché in esso viene esaminato per la prima volta il tema dell’asimmetria fra paure e pericoli. In particolare nel trattato i due autori si occupano della paura dei fulmini e della sproporzione fra tale paura, spesso vivissima, e il pericolo oggettivo, modestissimo, di essere effettivamente colpiti da una saetta.
Perché ci interessa questo lavoro di due lontani (e sconosciuti, al di fuori della cerchia degli specialisti) filosofi francesi? Perché in esso viene esaminato per la prima volta il tema dell’asimmetria fra paure e pericoli. In particolare nel trattato i due autori si occupano della paura dei fulmini e della sproporzione fra tale paura, spesso vivissima, e il pericolo oggettivo, modestissimo, di essere effettivamente colpiti da una saetta.
Nel mondo in cui viviamo — complesso e per molti aspetti indecifrabile, ben più di quello del diciassettesimo secolo — quello che molti di noi credono sulla consistenza dei pericoli ha poco a che fare con i pericoli oggettivi. In una duplice direzione: ci preoccupiamo per eventi o fenomeni assai improbabili e al tempo stesso, proprio per la medesima ragione (l’incongruenza fra paure e rischi), ci esponiamo a gravi pericoli senza alcuna consapevolezza.
Un mio amico ha, come tanti, paura di volare e dunque per nessuna ragione sale su un aereo, notoriamente il mezzo di trasporto più sicuro che esista. Però viaggia alla guida della sua potente vettura, spesso superando i centocinquanta chilometri all’ora, convinto di avere tutto sotto controllo ma in realtà esponendosi a un rischio di gran lunga maggiore rispetto a quello, minimo, del volo moderno.
Se il rischio è volontario ci sembra più basso e governabile; se ci viene imposto da altri o non si ha la possibilità di controllarlo — come nel caso delle epidemie — viene percepito, soggettivamente, con molto maggiore intensità.
Le influenze normali producono oltre seimila decessi all’anno per cause dirette e indirette. L’inquinamento dell’aria produce da cento a duecento decessi al giorno in Italia, eppure nessuno pare preoccuparsi di questo rischio, rispetto a quelli connessi all’attuale epidemia. La possibilità di entrare in contatto con un virus misterioso mette in moto una preoccupazione diversa e, per quanto possa apparire assurdo, maggiore rispetto a quella di respirare particelle cancerogene. Questo è uno dei tanti segni della nostra irrazionale relazione con il mondo e l’incertezza.
Parlando di paura viene naturale passare alla questione del coraggio, individuale e collettivo; dei cittadini e di chi ha responsabilità pubbliche. Certo non è una manifestazione di coraggio porre in essere reazioni sproporzionate, formulare dichiarazioni non sempre composte al solo scopo di sottrarsi all’eventuale futura contestazione di non aver fatto tutto quello che era necessario.
Il coraggio è una dote del carattere ma anche dell’intelligenza: esso consiste fra l’altro nella capacità di entrare in un rapporto razionale ed equilibrato con il pericolo e il rischio, gestendoli nei limiti in cui questo è possibile.
 In questa accezione di virtù dell’intelligenza, il coraggio assomiglia molto a quella che John Keats chiamava «Capacità Negativa». Questa, per il poeta inglese, era la dote fondamentale dell’uomo in grado di conseguire risultati autentici, di risolvere davvero i problemi e superare le difficoltà.
In questa accezione di virtù dell’intelligenza, il coraggio assomiglia molto a quella che John Keats chiamava «Capacità Negativa». Questa, per il poeta inglese, era la dote fondamentale dell’uomo in grado di conseguire risultati autentici, di risolvere davvero i problemi e superare le difficoltà.
Keats chiamò negativa questa capacità per contrapporla all’atteggiamento di chi affronta i problemi alla ricerca di soluzioni immediate, nel tentativo di piegare la realtà al proprio bisogno di certezze.
«Vi è capacità negativa quando un uomo è capace di stare nell’incertezza, nel dubbio senza l’impazienza di correre dietro ai fatti… perché incapace di rimanere appagato da una mezza conoscenza».
Per Keats, accettando l’incertezza, l’errore, il dubbio è possibile osservare più in profondità, cogliere le sfumature e i dettagli, porre nuove domande, anche paradossali, e dunque allargare i confini della conoscenza e della consapevolezza. Dunque risolvere i problemi.
Il senso di questa riflessione, riportato alle vicende odierne, è che bisogna affrontare la vita accettandone l’ignoto e la complessità. Bisogna affrontare il rischio prendendo tutte le precauzioni sensate (quelle suggerite dai veri esperti) ma non quelle insensate, generate da un bisogno immaturo e pericoloso di governare l’ingovernabile, cioè l’incertezza. Bisogna usare la paura come uno strumento di lavoro per cambiare le cose e non lasciare invece che diventi una forza incontrollabile e distruttrice.
Viene naturale chiudere queste riflessioni evocando la frase forse più celebre sulla paura, quella di Franklin D. Roosevelt pronunciata durante il suo discorso inaugurale, riferendosi alla Grande Depressione. È una frase che spesso è stata archiviata come un semplice gioco di parole. Il suo significato è però assai più ricco, va molto al di là dell’artificio linguistico. Il concetto espresso da Roosevelt è che, oggi come non mai, dobbiamo temere la paura — e combatterla e sconfiggerla con le armi dell’intelligenza — perché dalla paura non governata derivano conseguenze rovinose. Materiali e morali.
Gianrico Carofiglio Repubblica 26/2/2020
“Paura e ottusità sono i due carburanti essenziali per alimentare un regime degno di questo nome.”
Walter Fontana (1957), umorista e scrittore
Articoli che vi raccomandiamo di leggere:
Il populismo ha ucciso la politica


 In carica...
In carica...